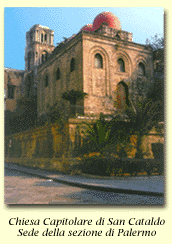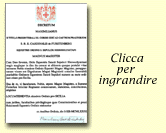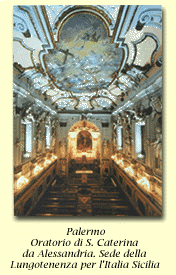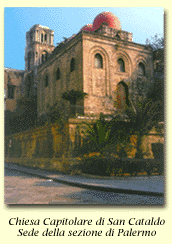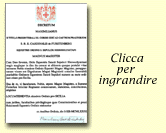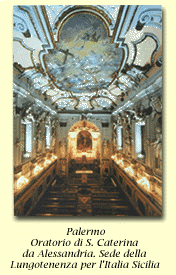Sotto la dominazione normanna, la Sicilia ebbe un nuovo assetto territoriale e più Principi cristiani fecero numerose concessioni alla Chiesa.
Il contado di Butera fu assegnato ad Arrigo, marchese di Lombardia. Il figlio di quest'ultimo, Simone Aleramico, nipote del conte Ruggero il Normanno, nell'anno 1096, al tempo della I^ Crociata, fondò ad est di Platea o Pluzia (oggi Piazza Armerina) un Gran Priorato dedicato a S. Andrea. L'importanza storica della Chiesa di Sant'Andrea è legata alla circostanza che essa rappresenta il primo priorato - protopriorato, appunto - che la Chiesa patriarcale del Santo Sepolcro di Gerusalemme ebbe in Sicilia.
Nel 1104 il fondatore Simone aggregò all'istituito Gran Priorato altre donazioni, e vi costruì un annesso monastero che fu dallo stesso zio di Ruggero dotato della chiesa di S. Gregorio con i suoi latifondi.
Nel 1106, insediatisi in Sicilia i confratelli del Santo Sepolcro di Gerusalemme, il Gran Priorato di
S. Andrea ospitò una comunità cenobita che visse sotto la regola dei canonici ''regolari di S. Agostino'' e il monastero fu ritenuto "gancia del Santo Sepolcro".
Nel 1262 il priorato di Sant'Andrea, per volere di Papa Urbano IV°, venne sottoposto all'esclusiva giurisdizione della Chiesa patriarcale di Gerusalemme, passando così alle dirette dipendenze del Patriarca Latino.
Questa comunità religiosa, uniformandosi alla disciplina degli Ospitalieri e dei Templari, armò i propri conversi con l'insegna delle cinque croci rosse, in memoria delle cinque piaghe di Gesù Cristo. I doveri di detti conversi erano quelli di garantire l'assistenza ai pellegrini diretti in Terra Santa e di combattere per la prosperità della fede e per la liberazione dei Luoghi Santi; ben presto, sostenuti dai Principi normanni, essi furono ricolmi di privilegi e di donazioni terriere e furono riveriti e temuti dal popolo.
Il conte Simone Butera, entusiasta della nobilissima istituzione, con diploma del 30 novembre 1144, oltre alle molte elargizioni ed ai privilegi concessi, assegnò al neopriorato di Piazza Armerina la chiesa di S. Giorgio, nelle vicinanze di Butera, e la badia di Santa Maria di Platea, con i rispettivi latifondi, il casale di Gallinica con la cappella di Sant'Agata e suoi terreni.
Con tutte queste concessioni e privilegi, il cenobio divenne floridissimo, e la S. Sede, così come ai pellegrini della Terra Santa, concedette particolari indulgenze a quanti visitavano la chiesa di S. Andrea di Piazza Armerina durante il periodo pasquale.
Caduta poi la Terra Santa in mano ai musulmani, passata quindi la Sicilia sotto i sovrani della Casa d'Aragona, nel 1446 i canonici regolari vennero sostituiti da quattro cappellani secolari. Sebbene questi ultimi continuassero a fregiarsi della croce potenziata rossa, il priorato cessò di appartenere all'Ordine del Santo Sepolcro per divenire un pingue beneficio che i sovrani aragonesi, e, via via, dopo questi, quelli spagnoli, austriaci, borbonici e italiani conferirono a ecclesiastici di loro fiducia.
Il Gran Priore pro-tempore fu innalzato in epoca più recente alla dignità dei Pari del Parlamento di Sicilia, il più antico Parlamento d'Europa.
Il Parlamento si componeva di tre bracci: l'ecclesiastico, che comprendeva 66 prelati; il militare che annoverava 58 principi, 27 duchi, 37 marchesi, 27 conti, un visconte e 79 baroni; e il demaniale che comprendeva 43 rappresentanti delle città regie. Questo sistema legislativo durò fino al 1815, anno in cui
Ferdinando I° abolì la rappresentanza siciliana e instaurò il governo assolutista.
Oggi questo monumento è di nuovo affidato alle cure dei Cavalieri del Santo Sepolcro.
Un altro antico priorato è quello della chiesa di S. Croce in Messina. Questa antichissima chiesa, costruita fuori le mura della città, sotto i Normanni (sec. XII) ospitò prima i canonici regolari di S. Agostino e fu unita poi al monastero del S. Sepolcro in Gerusalemme.
Tuttavia scarsi, e talvolta con informazioni tra loro divergenti, sono i documenti sulla presenza dell'Ordine Equestre del S. Sepolcro in Sicilia attraverso i secoli.
Nel 1932 esso contava solo pochi cavalieri ed il Luogotenente, nominato dal Patriarca Latino di Gerusalemme, avviava l'opera di riorganizzazione determinando così la rinascita dell'Ordine nell'isola.
Con le riforme statutarie dell'Eminentissimo cardinale Canali, la Sicilia fu divisa in due Sezioni - Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale – e nella Delegazione Luogotenenziale di Messina, alla dipendenza della Luogotenenza per l'Italia Meridionale con sede a Napoli.
Durante gli anni della ricostruzione fu assegnata all'Ordine Equestre del S. Sepolcro la gestione e la fruizione di prestigiose chiese: quella Capitolare di S. Cataldo (1937) e l'Oratorio di S. Caterina d'Alessandria (1946).
Il rilancio dell'Ordine è stato favorito prima, in data 6 ottobre 1980, con la istituzione della Delegazione Magistrale, e successivamente, in data 1 dicembre 1981, con il ripristino della Luogotenenza per l'Italia Sicilia, divisa oggi nelle Sezioni di Palermo - da cui dipende la Delegazione Locale di Trapani - , di Catania - da cui dipende la Delegazione Locale di Piazza Armerina -, di Messina - da cui dipende la Delegazione Locale di Patti - e di Siracusa.
Dal 1997 Luogotenente per la Sicilia è S. E. il Cav. Gr. Cr. Prof. Avv. Antonio Mistretta mentre Cancelliere è il Cav. Gr. Cr. Antonio Lo Monaco.
I Cavalieri, appartenenti alla Luogotenenza dell'Italia Sicilia hanno avuto concesso il privilegio di applicare sul mantello, ed esattamente sul colletto, due bottoncini dorati con l'insegna delle cinque croci rosse.